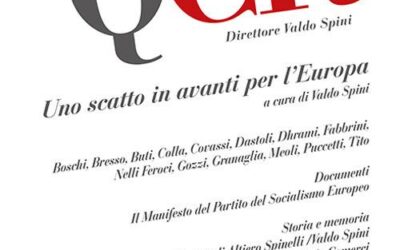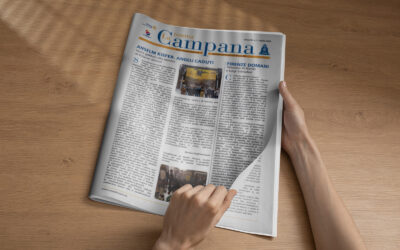Un tram chiamato metropoli
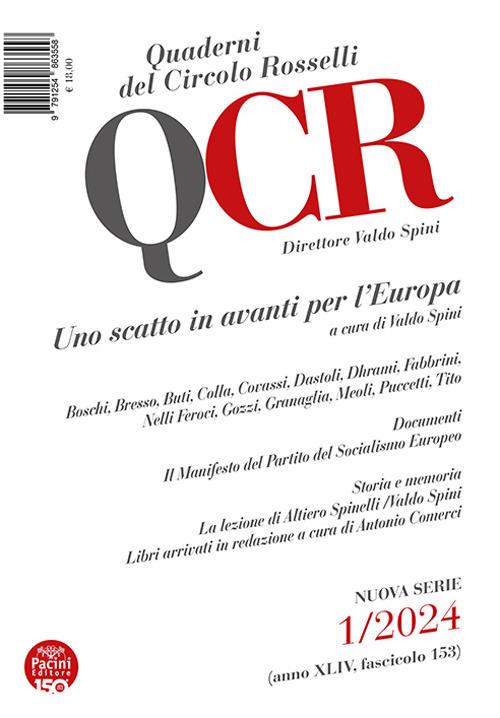
di Massimo Morisi
Il messaggio del padre
Partiamo per l’appunto da lui, da Beppe Matulli. Uno degli ultimi politici di calco degasperiano che Firenze abbia conosciuto. Ossia, un politico che ha vissuto professionalmente non solo di politica ma per la politica, dunque perseguendo una missione, una causa, un disegno o una chiamata eticamente “superiore” alle proprie ambizioni, per quanto funzionali già di per sé al perseguimento dell’interesse pubblico. E rispondenti a quella religione civile, prima ancora che cattolica, che assume come compito esistenziale di un amministratore pubblico l’agire al servizio del prossimo, della città e delle sue capacità di attivare e integrare nuove energie individuali e collettive. Parliamo, per ciò stesso, di un politico non anchilosato dal qui ed ora. Ma attento ai giorni del suo presente se e in quanto esso serva al domani di coloro che, prima o poi, quel domani vorranno viverlo, guidarlo e non solo subirlo. E, potremmo aggiungere, presupponendo che le azioni del rappresentare e del governare debbano trovare un appropriato riscontro fattuale sia nell’efficacia di conseguenti piani e progetti, sia nella coerenza con espliciti giudizi di valore che legittimino, in termini etici e strategici, quei piani e quei progetti, poiché anche e proprio il vivere e l’abitare una città pongono questioni che richiedono in chi la governa una visione del mondo realistica ma coraggiosa.
Ebbene, in questa prospettiva, tranvia diventa una delle parole chiave della riflessione di Beppe Matulli sul futuro di Firenze, a valle di uno sterile dibattito pubblico durato troppi decenni e che solo la sua caparbia intelligenza politica, il valore che egli attribuiva alle buone mediazioni e il suo senso della “repubblica” e dell’amministrazione municipale hanno contribuito a collocare finalmente al centro dell’agenda urbana[1]: nel faticosissimo tentativo, ancora lungi dalla meta ai nostri giorni, di convincere la città, i suoi residenti, i suoi abitanti, i suoi utenti a non adattarsi alla dittatura dell’automobile[2] se si vogliono coniugare sostenibilità e responsabilità ambientale sulla scala dei comportamenti individuali e delle intelligenze collettive. E se si addiviene, come è possibile se qualcuno tra politici e intellettuali si impegna in un simile orientamento del pubblico sentire, alla piena consapevolezza che la forma di una città è modellata dai nostri movimenti soggettivi e collettivi, e dalle modalità che quegli stessi movimenti assumono giorno per giorno, momento per momento. Va aggiunto, se si leggono con attenzione le implicazioni del lascito “matulliano” che i modi e i ritmi della mobilità urbana sono destinati a divenire parte costante e saliente del paesaggio fisico e sociale della città di Firenze e delle sue articolazioni metropolitane; così come della sua attrattività e della sua capacità di aggregare e integrare persone, talenti, risorse, bisogni, opportunità. E di mitigare – se non assorbire – le discriminazioni, le separazioni e financo le repulsioni che la città può produrre o favorire mediante i modi effettivi in cui si muovono e interagiscono coloro che ne vivono il territorio in una qualche misura e per una qualche funzione. Ed è appunto la tranvia, nel contesto territoriale fiorentino, a costituire una matrice sostanziale sia dello scenario metropolitano in cui si colloca la città, sia del divenire del suo paesaggio urbano. Come dire: la tranvia si va configurando come una nuova “invariante strutturale”; ossia una infrastruttura le cui dimensioni e il cui funzionamento sono in grado – di fatto, va rimarcato – di esprimere e dettare vincoli, indirizzi e regole di governo urbano e metropolitano che incorniciano, condizionano e stimolano – ad un tempo – i parametri vitali della città[3].
Dal tram alla metropoli?
Ma c’è un altro profilo interessante nel messaggio di Matulli. Al netto dell’immaginario turistico globale che la pervade come città-mito, Firenze è e permane una piccola città. La sua economia deve ricercare al di fuori dell’angustia dei suoi confini quell’efficienza, quella produttività e quella capacità redistributiva che il solo mercato turistico non può garantire dato il suo funzionamento sostanziale, sempre a cavallo tra economia formale ed economia informale, e date le implicazioni che ne derivano – “ad esempio” – sul mercato degli affitti.
La tranvia si colloca su questo sfondo e sulla scia di questo schema, in apparenza (ma solo in apparenza) “obbligato”, ossia considerabile tale sul piano storico e strutturale ma in realtà abbondantemente e diffusamente voluto e condiviso dai tanti fiorentini che sono “vittime” e “carnefici” di uno stesso sacrificio della città sull’altare della speculazione turistica.
È proprio su tale sfondo che la tranvia deve completarsi nelle linee già previste e in quelle immaginate e immaginabili; e correlarsi organicamente agli snodi e alle reti del trasporto pubblico e della mobilità privata: a scala locale, metropolitana e regionale. Solo così la tranvia può e potrà finalmente conferire alla città quel respiro metropolitano da sempre agognato a fronte dei vincoli e dei confini soffocanti delle rendite economiche e politiche. Parlo di “respiro”, certo: non di visione compiuta e condivisa; non, purtroppo, di un orizzonte progettuale e operativo già solido a scala metropolitana, perché ancora a quel livello di governo e di coordinamento – effettivo e non solo conclamato – né l’amministrazione comunale né la città metropolitana come istituzione paiono essere giunte. Prova ne sia la evidente inconsistenza culturale e normativa del piano strategico della città metropolitana fiorentina. Una dimensione politico-amministrativa e analitico-progettuale sempre evocata e auspicata dall’applicazione della legge Del Rio ai giorni nostri, ma mai praticata come cornice ordinaria e come modalità operativa del pubblico amministrare urbano e interurbano dell’area metropolitana.
A questo punto la domanda è: la tranvia potrebbe/potrà mai costituirne un “correttivo” pur non essendo strategicamente concepita al conseguimento di tale scopo? Ossia, potrebbe/potrà mai produrre la tranvia tutta una serie di effetti indotti capaci di stimolare le amministrazioni interessate e le aggregazioni degli interessi potenzialmente in gioco, allo scopo di definire e condividere una nuova agenda territoriale della città? E potrà mai riuscirvi su una scala adeguata alla complessità dei temi e dei flussi di relazioni economiche e sociali che permeano lo stesso territorio della metropoli fiorentina e che attengono al suo quasi milione di abitanti?[4].
Certezze non ve ne sono. Ma se tali quesiti volessimo tradurli in una esplicita e intenzionale ipotesi programmatica e progettuale alla scala appropriata, ecco che la tranvia potrebbe aiutare la città a depurarsi dalle scorie vecchie e nuove di una firenzina abbarbicata a quella “non città” (…ma starei per dire, a quel non luogo) quale rischia paradossalmente di diventare il suo centro storico. Che tale è già nella quotidiana esperienza dei suoi residenti e nello sfruttamento delle rendite di posizione – grandi, multinazionali o pulviscolari che siano – che ne sono il sostrato[5]: sulla scia di una “monocottura” turistica che in modo diretto e indiretto continua ad alimentarsi lungo una spirale senza limiti, se non quelli (momentanei e densi di “pentimenti” prontamente smentiti una volta superata la bufera) delle grandi catastrofi globali come il covid, o quelli delle tensioni geopolitiche quando impongono restrizioni globali o regionali alla mobilità internazionale.
Insomma, la tranvia si configura come una grande innovazione nel modo di muoversi della città e, per ciò stesso, nel modo in cui questa si percepisce e nelle prospettive in cui la stessa concepisce il proprio funzionamento generale. La tranvia può infatti cambiare la geografia della città e le interazioni tra le persone e le funzioni urbane, conferendo alla dimensione metropolitana della città, e sarebbe la prima volta a Firenze, un’evidenza tangibile e concreta virtualmente per chiunque e non soltanto agli occhi di qualche studioso o praticante di discipline del governo del territorio o di qualche amministratore illuminato. La stessa mappatura anche dei soli tracciati esistenti così come di quelli in corso di progettazione si giustappone alle anguste visioni municipalistiche. E rimarca, se ve ne fosse ancora bisogno, come i confini tra territori, popolazioni e perimetri tematici non possano costituire il limite preventivo delle agende politiche e amministrative locali ma unicamente un loro eventuale risultato: ossia – sul piano delle questioni e delle implicazioni sostanziali – i confini possono rappresentare la conseguenza di un qualche disegno programmatico, non il suo postulato. E la tranvia, se si fosse abbreviata e semplificata la sua eccessiva incubazione progettuale e realizzativa, e se oggi venisse integralmente sviluppato il suo disegno urbano e interurbano mediante una progettazione ragionevole e attenta anche agli apparenti “dettagli”[6] ossia evitando soluzioni logistiche, tecnologiche ed estetiche di ripiego[7], e se – è bene ribadirlo – la stessa tranvia venisse ben correlata alle reti e agli snodi del trasporto pubblico e della mobilità privata su scala metropolitana e regionale, ebbene, soddisfatti simili “se”, la tranvia potrebbe “rimuovere” – col suo stesso funzionamento – i confini e le barriere intra e intermunicipali tra luoghi, funzioni, attività, servizi. E potrebbe razionalizzare e mettere in valore le interconnessioni che di fatto già esistono così come quelle potenzialmente attivabili lungo una grande pluralità di assi urbani e periurbani.
Da tutto questo deriva il potenziale metropolitano della tranvia. Cioè, la sua capacità di offrire alla metropoli fiorentina la trama di una molteplicità di inneschi per produrre coesione territoriale, dinamismo economico e sociale, rigenerazione ambientale associata a un’effettivo contenimento regolativo della pressione automobilistica e dei vettori turistici attorno al cuore storico della città. E, a dieci anni dalla istituzione di quelle città metropolitane che neppure a Firenze lasciano ad oggi intravedere tracce memorabili[8], l’avvento della tranvia e dei suoi pur defatiganti cantieri sembra ribadire un assunto generale: che le infrastrutture, se degnamente – va sottolineato: degnamente[9] – “messe a terra” – come recita il gergo degli urbanisti – possono supplire alle vaghezze della retorica politica o almeno mitigarne l’inconcludenza: aprendo scenari che riforme istituzionali invischiate nelle difese pregiudiziali dei confini storici e delle gerarchie pregresse, lasciano sovente sulla carta o non riescono neppure a immaginare o almeno a proporre al pubblico dibattito.
Il controllo degli effetti
Si può obiettare che neppure la migliore delle infrastrutture riesce mai ad apparecchiarsi come un pranzo di gala. Tanto meno la tranvia fiorentina. La quale, con i suoi epocali tempi decisionali e realizzativi, è andata inserendosi in un contesto di assetti e di funzionalità urbane perennemente e frammentariamente in movimento e dunque in scenari di temi, problemi e opportunità sempre diversi dalle situazioni e dalle prospettive immaginate al momento delle ideazioni e delle progettazioni originarie. Ciò significa che, quando i diversi rami della tranvia diventano finalmente funzionanti, a quelle stesse progettazioni originarie fanno seguito copiose messi di effetti non previsti, sovente contraddittori con le idee e le ipotesi di abbrivio. Ad esempio: chiunque può agevolmente osservare come oggi la tranvia possa ben diventare un ulteriore volano di overtourism. Lo sanno assai bene gli utenti “scandiccesi” quando sono costretti ad abbracciarsi in amorosi sensi con i visitatori mordi e fuggi che dal parcheggio autostradale di Villa Costanza – tra bagagli, panini e selfies – si dirigono come un sol uomo verso il centro storico o da questo all’aeroporto. Così come è un fatto che le nuove articolazioni espansive della tranvia stanno incentivando, già in sede di attese di mercato e di sollecitazioni delle agenzie immobiliari, l’offerta di affitti brevi a scopo turistico anche ben oltre la cerchia dei viali di circonvallazione – da Campo di Marte a Novoli, da Bagno a Ripoli a Sesto Fiorentino e via dicendo – alimentando l’estendersi pervasivo del mercato degli airbnb e dei suoi corollari a bassa trasparenza, con le conseguenti distorsioni dell’offerta immobiliare e i processi di sostituzione residenziale e funzionale che vi conseguono. Si può controbattere, in proposito, che una politica pubblica, come qualunque farmaco, non è mai priva di effetti indesiderati: non sempre convertibili in opportunità positive, né quasi mai computabili ab origine[10]. Ed è un dato di fatto: proprio perché qualunque politica pubblica, anche tra quelle infrastrutturali, è pensata e proiettata attorno a una visione che si autodefinisce “strategica” ma non sempre abbastanza attenta alle implicazioni intersettoriali e territoriali. E non sempre capace di apprendere dagli esiti che si rendano evidenti già in corso d’opera e di apportare le opportune correzioni anziché reiterare acriticamente il perseguimentodelle intenzioni[11]originarie. Per questo non c’è politica pubblica che non abbia bisogno del supporto di attività e di strumenti di verifica dei suoi effetti diretti e indiretti al fine di non disperderne le potenzialità generali, specie se si tratta di un progetto innovativo di mobilità e dunque di vivibilità urbana. Di qui l’esigenza di un monitoraggio attento, continuativo e metodologicamente attrezzato che tenga sotto osservazione sistematica – nel caso fiorentino – l’impatto della tranvia sulle principali variabili economiche e sociali della città – inclusa la fase di cantierizzazione – oltre che sulle dinamiche del trasporto pubblico e privato, e non solo sulle pur importantissime inferenze che se ne possono trarre ai fini di una valutazione della qualità ambientale della vita urbana e della sua evoluzione. Ma resta essenziale che dalle risultanze di un simile monitoraggio costante vengano tratte via via le dovute conseguenze: almeno per rimodellare o mitigare gli effetti problematici e valorizzare quelli virtuosi sia nella prospettiva del breve quanto in quella di lungo andare.
La tranvia nel paesaggio urbano[12]
«L’architetto Alberti diede un contributo originale di ripensamento di diverse soluzioni nelle linee 2 e 3, soprattutto in riferimento alla qualità dell’impatto urbano. In particolare suggerì la possibilità/opportunità di mantenere lo spazio riservato alla tranvia in una sola metà di via dello Statuto, non alterando l’attuale assetto della via con gli alberi al centro della strada nelle aiuole spartitraffico. Inoltre ridisegnò l’impatto della tranvia in Piazza Dalmazia e dintorni con una soluzione che trovò anche l’entusiastica approvazione degli operatori del locale mercato»: sono ancora parole di Matulli[13]. Ed è utile rammentarle non solo per l’omaggio a un valente e generoso urbanista fiorentino ma perché offrono un ottimo esempio di quanto gli effetti ragionevolmente prospettabili in seguito all’avvento e al funzionamento di una nuova infrastruttura urbana a largo spettro come la tranvia, possano e debbano trovare piena e consapevole ospitalità nel lavorio di progettazione così come nei suoi affinamenti progressivi. Che sempre sono necessari e inevitabili a fronte delle questioni, dei problemi e delle opportunità conseguenti alla messa in opera e all’attivazione di nuovi servizi di mobilità. Un’opera come la tranvia, insomma, non solo ha un impatto cospicuo e di palmare evidenza sul paesaggio urbano ma ne produce anche di nuovo: e non una volta per tutte bensì nella continuità e nell’evolversi diacronico del suo funzionamento. E nel mutare dei modi, delle platee, dei significati e delle molteplici funzionalità della sua fruizione urbana e metropolitana.
Tutto questo è abbastanza ovvio e prevedibile. Meno scontato è capire se e come un impatto così vistoso come quello che la tranvia sta arrecando al paesaggio urbano possa anche rappresentarne o stimolarne progressivamente una percezione positiva e nuovi modi di osservare e avvertire i luoghi, gli spazi e le interazioni di cui vive la città nella sua articolazione metropolitana. È come domandarsi, cioè, se e come sia replicabile e generalizzabile – mutatis mutandis – qualcosa di simile a quanto è avvenuto con la linea 1 nel territorio di Scandicci e tra Scandicci e Firenze: ove la ricucitura intercomunale che la tranvia opera ogni giorno ha aperto finestre e prospettive paesaggistiche a lungo celate dagli affanni e dalle frammentazioni della mobilità privata, e da una viabilità conseguente alle contingenti pulsioni del mercato edilizio e al suo potere conformativo per il lungo periodo.
Il fatto è che la tranvia modifica, anzi trasforma il volto, le funzioni e l’uso di vie, piazze e visuali – dalle più celebrate a quelle più inusuali; nei quartieri “storici” (che a Firenze sono sia centrali che periferici) così come in quelli periurbani del tessuto metropolitano. E se è vero che archivia tante “cartoline” del nostro immaginario e del vissuto che sottende, la tranvia può anche rinnovare lo stesso modo di avvertire le dimensioni spaziotemporali della città “vasta”, offrire nuove occasioni per nuovi scorci, nuovi sguardi e nuove affezioni variamente georeferenziate entro un territorio grande e dai molti sembianti a lungo inusitati nella nostra quotidianità e nelle sue interconnessioni.
È un’ipotesi al limite del wishful thinking ma può avere una briciola di plausibilità se riesce a coinvolgere l’insieme della popolazione metropolitana, a partire dalle fasce più anziane, poiché in quelle più giovani il confronto tra la Firenze del “dov’era e com’era” e la complessità delle politiche dell’oggi viene assorbito, com’è fisiologico, da una modernità visibile e in azione che si fa contesto “naturale”. Ma è comunque un’ipotesi legata alla soddisfazione di una banalissima esigenza preliminare. Quella di una comunicazione adeguata come parte costitutiva del processo di progettazione, di cantierizzazione, di messa in funzione dell’infrastruttura e dei suoi servizi. In grado, dunque, di ben spiegare, motivare, coinvolgere: non solo in merito ai disagi provocati dalla costruzione di una grande e difficile opera pubblica, ma anche al fine di promuovere nelle diverse categorie di residenti, di abitanti e di fruitori della città, la consapevolezza di un nuovo e grande orizzonte “territoriale”[14] in cui situare il succedersi e l’alternarsi di vecchi e nuovi riferimenti. E di nuovi legami con i luoghi e gli spazi in cui si articolano e si sviluppano una metropoli e la sua offerta interconnessa di beni pubblici e funzioni collettive. Luoghi e spazi che a loro volta, ma su questo non mi soffermo, vanno preparati, ossia qualificati e rigenerati quando serve, per assurgere a tale ruolo.
Per concludere
Nel rileggere questi appunti mi rendo conto di un mio ottimismo forse troppo “volenteroso”. Ma credo che le politiche pubbliche più complicate e innovative – e la realizzazione della tranvia fiorentina ne costituisce un caso emblematico – possono aver successo se spingono i loro obiettivi oltre gli scenari di ciò che qui ed ora ci sembra unicamente “possibile”.
[1] Un “vasto programma” che lo stesso Matulli spiega nei suoi presupposti culturali oltre che politico-amministrativi e nel suo impatto sistemico sulla struttura urbana e sulle sue dinamiche essenziali, in G. Matulli, La tranvia e la città, Firenze, Edizioni Polistampa, 2013.
[2] Rovesciando, cioè, la solenne profezia di George Pompidou il quale, da Presidente dei francesi, asseriva il contrario, ossia che «…le città dovevano adattarsi all’auto», come ricorda lo stesso Matulli in G, Matulli, La tranvia e la città, cit., p. 8. Profezia che continua a rivelarsi “vincente” se anche a Firenze, nonostante la tranvia e le potenzialità salvifiche che le vengono attribuite da chi governa la città, si continuano a promettere, nella campagna elettorale per le amministrative del giugno 2024, nuove migliaia di parcheggi auto nel tessuto urbano della città (vedi il programma presentato dalla candidata del Sindaco, Sara Funaro: «Creo 10 mila parcheggi grazie a supermercati e vecchie aree dismesse», in “La Nazione”, cronaca di Firenze, 27 aprile 2024, p. 5). È da sperare che qualcuno un minimo di conti in termini di carico urbanistico e ambientale, oltre che di ipotesi di fattibilità, li abbia fatt. Ma, trattandosi di promesse elettorali, è lecito fermarsi all’auspicio.
[3] Configurandosi appunto come una di quelle invarianti strutturali previste dal vigente Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT): uno dei pochi “piani paesaggistici” che le regioni italiane abbiano saputo partorire (5 regioni su 20) in applicazione del Codice nazionale dei beni culturali e del paesaggio: Puglia, Toscana, Friuli, Piemonte e Lazio. Regioni alle quali possiamo aggiungere la Sardegna pur nelle peculiarità funzionali del suo piano. Orbene, nella Disciplina di piano del PIT della Toscana laddove si definiscono gli elementi patrimoniali del territorio e gli elementi normativi dello “Statuto del territorio toscano” (capo primo, art. 6, comma 2, lettera c) viene appunto annoverata «la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali [corsivo nostro], artigianali industriali e tecnologici».
[4] Per la verità 987.664 residenti censiti dall’Istat al dicembre 2023 (demo.istat.it), ovviamente al netto dei residenti di Prato e di tutti i Comuni che integrano sul piano relazionale e funzionale la città metropolitana fiorentina ma purtroppo non ne sono parte formale.
[5] «Vorrei che la città tornasse un po’ ai cittadini e non fosse solo schiacciata dal turismo, il turismo andrebbe gestito. Stiamo parlando di una città dell’Unesco, […] in questi ultimi 8 anni la città si è molto alienata dalle sue origini, non c’è più un negozio, una bottega normale ma tutte esclusivamente per turisti con gadget, souvenir e questo andrebbe frenato. È già tardi e non si torna più indietro, perché dopo che una città è diventata meretrice sarà difficile farla tornare vergine. E se non si mette adesso un freno assoluto, non vedo più speranza», così Cecilie Hollberg, Direttrice della Galleria dell’Accademia, nella conferenza stampa del 28 gennaio 2024 (cfr. M. Leardi, “Firenze meretrice”. Bufera su Hollberg, Sangiuliano valuta provvedimenti, in “www.ilgiornale.it“, 29 gennaio 2024). A sostegno di tali parole e in controtendenza rispetto alla generale indignazione che hanno suscitato presso le istituzioni locali e ministeriali – G. Pallanti, Hollberg ha detto la verità, in “La Nazione”, 30 gennaio 2024, rimarca: «Altro che indignarsi perché la direttrice Cecile Holberg ha definito Firenze, in senso lato, una “città meretrice”. Infatti essa si vende al miglior offerente. Ci sono decine di ristoranti in mani a cittadini extra europei, nessuno sa con esattezza chi finanzia molte attività del circuito turistico gestito da imprenditori provenienti da nazioni caratterizzate da economie povere o poverissime. Quante sono le holding alberghiere e immobiliari che hanno acquistato spazi vitali della nostra città?».1
[6] Alias talunesciatte, al limite della malvagità, “iperpalificazioni” anche nelle parti di maggior pregio del paesaggio urbano, come attorno all’abside della cattedrale di Santa Maria Novella.
[7] Prevenendo, ad esempio, le incomprensibili incertezze circa il modo di servire il polo universitario di Sesto Fiorentino.
[8] Lo rimarca G.F. Cartei, Le Metrocittà. Dieci anni senza svolta, in “Corriere fiorentino”, 7 aprile 2024.
[9] Degnamente è avverbio che mutuo da una splendida pagina di Giorgio Bassani quando parlava del «…nostro perpetuo battagliare, da anni, in favore di città dove sia dato luogo al bisogno di verde, di spazio e di silenzio, che caratterizza le età estreme dell’uomo, l’infanzia e la vecchiezza, in favore di città “degne” – per dirla con Cederna – “veramente moderne”, mi sembra perfettamente espresso, per contrasto, da questa tragica immagine, riassuntiva della barbarie di tanti insediamenti urbani creati dalla incontrollata speculazione edilizia» (G, Bassani, Intervento di apertura della mostra “Italia da salvare”, pubblicato poi col titolo Discorso di Bassani, Presidente di Italia Nostra, in BIN, n. 53, 1967, pp. 49-53, poi ancora, qui citato, in G. Bassani, Italia da salvare. Gli anni della Presidenza di Italia Nostra – 1965-1980 –, Milano, Feltrinelli, 2018, p. 53). Che poi il funzionamento della tranvia e dei sistemi correlati di trasporto pubblico locale e metropolitano contribuiscano al “verde”, allo “spazio” e al “silenzio” è questione del tutto dipendente, lo abbiamo già rimarcato, dallo strumentario progettuale e pianificatorio – e dalla configurazione tecnologica ed estetica – di cui la stessa tranvia sia parte e magari anche motore.
[10] Il fatto è che lo sviluppo, l’innovazione, la modernizzazione, la perequazione, la correzione ed ogni altra parola che evochi una qualche “riforma”, insieme ai piani, ai programmi e ai progetti che ne perseguono ragioni e obiettivi all’interno di politiche pubbliche specifiche, danno vita a «un continuo vai e vieni tra la pianificazione e la vita, tra l’intenzione calcolante (target misurabili, KPI –key performance indicator -, indicatori di efficacia) e le potenze della varietà e della pluralità delle pratiche di vita, a partire da quell’atteggiamento di reverence for life che non dovremmo mai dismettere», secondo il classico insegnamento di Albert Hirschman, che Gabriele Pasqui ha recentemente rivisitato tra i pensatori di quella che potremmo chiamare la “pianificazione critica”. Cfr. G. Pasqui, Gli irregolari. Suggestioni da Ivan Illich, Albert Hirschman e Charles Lindblom per la pianificazione a venire, Milano, Franco Angeli – Collana del DAStU, Politecnico di Milano, 2022, p. 87ss..
[11] Cfr, P.L. Crosta, C. Bianchetti, Conversazioni sulla ricerca, Roma, Donzelli, 2021, p. 15.
[12] Non è questa la sede ma si potrebbe andare al di là del senso comune e chiedersi cosa si possa intendere, ammesso che lo si voglia, per “paesaggio urbano”. E sarebbe un quesito non poi così frivolo o peregrino come potrebbe apparire. Non è un caso che uno dei più autorevoli promotori italiani della tutela del paesaggio del nostro Paese – Salvatore Settis – ritenga di dover porre in evidenza che «La campagna (il paesaggio) [sic], proprio perché marginalizzata, subordinata e sacrificata al disegno di espansione indeterminata delle città, diventa il necessario contraltare e complemento di ogni discorso sulla città» (così appunto S. Settis, Architettura e democrazia. Paesaggio, città, diritti civili, Torino, Einaudi, 2017, p. 82) rimarcando con ciò, pur implicitamente, quanto una nozione concepita propriamente per la città e il divenire del suo territorio urbano non sia identificabile, sic et simpliciter, con una nozione di paesaggio: che pare richiamare, anche nella riflessione più colta, un campo semantico extra o peri urbano. D’altra parte, è un’indefinitezza concettuale che, dal Bel Paese dell’abate Antonio Stoppani (vedi appunto A. Stoppani, Il Bel Paese, 4ª edizione, Milano, Agnelli, 1883; ristampa Milano, Lampi di stampa, 2005), giunge alle origini della Repubblica attraversando la formazione del secondo comma dell’art. 9 della Costituzione. E non sembra venir superata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nelle sue diverse versioni. Né trova accoglienza specifica e dichiarata nella stessa Convenzione europea del paesaggio. Si badi, non v’è dubbio che “paesaggio” sia lemma iperpresente nella normazione, nella giurisprudenza e nella dottrina inerenti al governo dell’ordine urbano e del suo sviluppo, attraverso il lungo viaggio normativo che collega le “premesse ottocentesche” al “post-Novecento” della sostenibilità (cfr. P. Passaniti, Il diritto cangiante. Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano, Milano, Giuffrè – nella collana fondata da Paolo Grossi e diretta da Paolo Cappellini Per la storia del pensiero giuridico moderno – 2019, che appunto ripercorre e analizza efficacemente la vicenda ultrasecolare del diritto “paesaggistico” dell’Italia unita). Ma ciò che è difficile rinvenire è un sostrato concettuale specifico, ossia pensato ed elaborato per la città contemporanea e per le sue dinamiche funzionali e morfologiche e non solo per le sue correlazioni con la “ruralità” degli ambiti territoriali esterni alle “mura” urbane o interclusi al loro interno, per quanto essenziali siano quelle stesse correlazioni alla configurazione fisica della città e dei sistemi territoriali di cui è parte (su cui, G. Corsani, La città e le virtù attrattive del paesaggio, inA. Magnier, M. Morandi – a cura di – Paesaggi in mutamento. L’approccio paesaggistico alla trasformazione della città europea, Milano, Franco Angeli, 2013, pp.25-37). Ci si può dunque chiedere quali siano i “formanti” del paesaggio urbano nella contemporaneità. E se si ipotizza l’ammissibilità di una specifica nozione di paesaggio urbano, quali dovrebbero essere gli “indicatori paesaggistici” da individuare e utilizzare per definirne le proprietà e la qualità. E ancora: qual è il rapporto tra paesaggio urbano, qualità dell’abitare e del vivere personale e collettivo, e i caratteri dello sviluppo economico e sociale di una città e della sua capacità inclusiva e integrativa? Che è come chiedersi: possiamo ritenere il paesaggio urbano una risorsa o un vincolo per l’attrattività e la capacità di quella stessa città di produrre e distribuire opportunità, servizi e benessere tra i suoi abitanti? È insomma quel paesaggio la forma riflessiva di un contesto insediativo e delle sue dinamiche o ne è anche una matrice attiva?
[13] Come ricorda lo stesso G. Matulli, op. ult. cit., p. 24, nota 3.
[14] Territoriale è aggettivo per l’appunto ovvio e decisivo. Perché, senza scomodare la riflessione né l’argomentazione territorialista che Alberto Magnaghi propose e sviluppo’ a suo tempo nell’urbanistica italiana, è il territorio l’anima, la logica e il motore mobile di ogni paesaggio – della città e nella città, oltre che nel suo “intorno” vicino e lontano – e delle sue chiavi esplicative. Il paesaggio narra; il territorio spiega. Ciò, perché il territorio non è una categoria dello spirito, ma neppure il solo persistere o il solo mutare dell’insieme dei beni e delle immagini che costituiscono la sua fisicità. Il territorio, semplicemente, è la sintesi del passato e del presente dei fenomeni che accoglie e del modificarsi conseguente delle sue strutture visibili e sottese. Una sintesi di passato e presente che coloro che vivono quel territorio offrono qui ed oggi. In una parola, nelle circostanze date, il territorio siamo “noi”: come insieme di persone che abitano o usano o attraversano le nostre città e i nostri borghi, le nostre colline, i nostri boschi, le nostre fabbriche e i nostri distretti, le nostre strade, le nostre ferrovie, i nostri porti, le nostre periferie, i nostri centri storici. Ma anche le nostre scuole, i nostri teatri, le nostre università, i nostri ospedali, i nostri musei, le nostre piazze, le nostre stazioni. Persone di antico o nuovo insediamento che conservano o innovano le ragioni e i modi in cui utilizzano e mettono in valore le risorse di quel territorio, così come antiche e nuove relazioni di comunità, di vicinato, di scambio, di solidarietà o di conflitto. Il territorio è perciò anche l’insieme dei modi di pensare, di credere, di nutrirsi, di colloquiare e lavorare tra chi in una città nasce e vive e tra chi viene da altri mondi e altri vissuti. Ma anche il nostro “muoverci” nella città, tra le città e verso i loro contesti extra urbani è una componente di una data compagine territoriale: con il quotidiano transitare dei saperi, delle merci e delle informazioni cui partecipiamo o di cui ci avvaliamo sia nell’organizzare il nostro lavoro, sia nel predisporre quanto dell’esistenza riusciamo a liberare o a preservare dall’offerta di prestazioni cui il mercato ci sollecita.
Il territorio è, insomma, quell’intreccio di esperienze individuali e collettive che dà significato e dignità di “luoghi” agli spazi in cui mettono una qualche radice le nostre esistenze e le relazioni che le alimentano. “Luoghi” che hanno o non hanno una loro “qualità” se e in quanto ci rendano riconoscibili e apprezzabili a noi stessi e dunque capaci di interloquire e interagire con il nostro prossimo, per vicino o lontano che sia nella sua origine, e non solo di diffidarne.
Così il territorio è quel noi che consuma o costruisce o conserva o trasforma i tanti luoghi che compongono il nostro presente in vista o in nome di un qualche futuro. Così come hanno fatto coloro che ci hanno preceduto nei tanti presenti in cui hanno vissuto. E così come continueranno a farlo coloro che ci seguiranno. Poiché il territorio è un costante e inesausto lavorìo di attività umane che mescola, da un lato, la materialità dei bisogni, delle domande e delle opportunità che si vogliono soddisfare mediante i beni e le risorse che il territorio offre e, dall’altro, l’immaterialità dei valori culturali, comunitari, estetici e simbolici che il territorio racchiude, nel costante divenire del suo paesaggio: …tra retaggi e trasformazioni della sua forma visibile.
È un divenire fatto del susseguirsi al presente di visioni e concezioni del futuro: visioni di breve e lungo termine, egocentriche e altruistiche. Visioni alimentate e legittimate dalla razionalità della storia e dalle sollecitazioni individuali e collettive che la esprimono: ove agiscono i conflitti e le solidarietà, le mani visibili e invisibili del mercato e il giustapporsi del lavoro creativo e della impresa innovativa, da un lato, così come della loro rimozione nella rendita di posizione, dall’altro. Con le alleanze e le asimmetrie sociali che ne derivano insieme al confronto e alle tensioni tra vecchi e nuovi diritti e vecchi e nuovi interessi. Una razionalità storica – pertanto – che è il risultato della osmosi dialettica tra regolazione economica e regolazione politica.